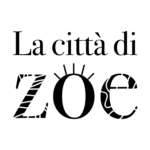Di Giovanni Caruso e Matteo Iannitti
Un gruppo di una quindicina di ragazze e ragazzi, sedute a cerchio, intorno a un tavolo pieno di computer, in un bene confiscato alla mafia in Sicilia. Su zoom altre due in collegamento dal Piemonte e dalla Lombardia. La voglia di scrivere un nuovo numero del giornale. Di cosa scriviamo? Perentoria Francesca ha la risposta. “Di sfruttamento”. “Di noi che veniamo sfruttate, che siamo costrette ad andarcene”. “Brava, giusto” fanno eco le altre ragazze. Ogni anno dalla Sicilia vanno via ventimila persone per andare a vivere, studiare, lavorare, curarsi in altre parti d’Italia e del mondo. “Scriviamo di quando ci tengono a lavorare in nero, per tre euro l’ora, di quando ci licenziano da un giorno all’altro, con un messaggio su whatsapp, di quando il titolare ci fa pagare la cena, durante il nostro turno come cameriere al suo ristorante”. “Scriviamo di quando siamo costrette a partire da un giorno all’altro, per prendere un posto pubblico dall’altra parte d’Italia. Ci chiamano come se fossimo schiave, come fanno i caporali”. “Scriviamo di noi che non vogliamo partire”. “Ma anche di chi deve avere il diritto a partire”. “Chiamiamo Mimmo Lucano, chiediamo a lui come si fa accoglienza in un luogo di emigrazione”. “Chiamiamo le compagne di Palermo per farci raccontare la loro storia sui diritti delle migranti queer”. “Ci possiamo mettere le illustrazioni? E la musica?”. “Ci pensa Abramo”. “Chiamate Dario, fate scrivere un pezzo a Dario. Chi lo chiama Dario?”. “Fai tu, Luca?”. “Ci penso io”. Se Dario sarà riuscito a chiudere il suo articolo entro la pubblicazione di questo numero lo scoprirete sfogliando le prossime pagine.
Funzioniamo così. Come una piccola banda di giornaliste. Quello che sappiamo lo abbiamo imparato, o visto fare, nei Siciliani giovani, che è la nostra casa e la nostra sfida più grande. Nella Città di Zoe non è chiaro dove inizia l’attivismo e dove finisce il giornalismo, e viceversa. Ma questo siamo, senza nascondimenti: la webzine dell’Arci.
Andate via è un imperativo. Quando sei costretta a scappare da dove sei nata, che sia un piccolo comune siciliano o calabrese, o una grande città del Mali, del Gambia, del Bangladesh, dell’Egitto. Il tuo punto di arrivo potrà essere una capitale d’Europa o la grande città più vicina al tuo paese.
Andate via è un imperativo anche quando il padrone (o datore di lavoro, chiamatelo come volete!) ti caccia perché non servi più. Andate via è un participio. Nei racconti di chi ha scelto di cambiare aria, di scommettersi in luoghi diversi. Non per forza per questioni economiche, non per forza perché costretta, non per forza per ragioni di vita o di morte. Spesso solo per il gusto di esplorare, di vivere un’altra vita, di essere più felice, di inseguire orizzonti. C’è chi parte da Bronte e approda a Catania, c’è chi parte da Catania e approda a Torino, c’è chi parte da Torino e approda a Londra. C’è chi parte da Bamako e arriva a Riace.
Andate via torna imperativo quando siamo noi a impossessarcene e a pronunciarlo: “andate via!”
Un urlo liberatorio contro tutto ciò che non va, contro tutto ciò che ci impedisce di essere felici.