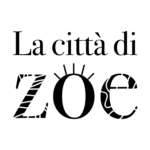Di Alessandro Motta
«Si erano accorti che c’erano tra noi uomini sazi e ingozzati di ogni sorta di beni di lusso, mentre altri stavano a mendicare alle porte, sbranati dalla fame e dalla povertà; e trovavano strano che quelli, così bisognosi, potessero sopportare una tale ingiustizia; che non prendessero gli altri per la gola o appiccassero il fuoco alle loro case»
Michel De Montaigne, Saggi
Siamo agli inizi del ‘500, nel mezzo di quel processo culturale che vuole deporre Dio dal trono della Storia e mettervi l’Uomo. Si ha fiducia che il soggetto potrà finalmente liberarsi, dominare la Natura, sottrarsi alle angherie della Fortuna e costruire, così, un mondo nuovo.
In tale contesto permeato di ottimismo, mentre tutti si affaticano a indicare la libertà come scopo, il diciottenne Étienne de La Boétie, nel «Discorso della servitù volontaria», si chiede per quale motivo molti decidano volontariamente di assoggettarsi al potere di uno solo. Di motivi ne individua quattro: l’abitudine, la propaganda, la convenienza, il desiderio di partecipare della ricchezza del tiranno.
L’autore si riferisce alla tirannide che tiene in pugno il popolo con un potere che gli viene concesso inconsapevolmente dalle masse, ma se sostituiamo “tiranno” con “padrone” e “popolo” con “lavoratorɜ” il discorso cambia poco. «L’abitudine ci nasconde il vero aspetto delle cose» sosteneva Montaigne. Per abitudine si intende l’idea che le cose non debbano mai cambiare o, peggio, che non possano cambiare, perché sono sempre andate così. Dall’abitudine alla naturalità il salto è breve: cominciamo a credere che sia naturale – e quindi necessario, immutabile, ineluttabile – quello di cui siamo solamente abituati. Come sostiene David Hume, l’abitudine è un’inclinazione naturale ad aspettarsi che le cose vadano nel futuro come sono andate nel passato e che domani sorgerà il sole perché è sempre sorto (e invece neppure il sole sorgerà per sempre). Crediamo, quindi, che la nostra subalternità sia una fatto naturale e immodificabile.
Poi, ancora, c’è l’uso strumentale della comunicazione e della conoscenza: se impedisci che le persone comunichino tra loro, se impedisci alle idee di circolare e di confrontarsi è più difficile che quegli animi rivoluzionari (che ci sono sempre!) possano costruire un processo di consapevolezza che non si fermi a loro stessi ma che coinvolga altrɜ, crei connessioni, produca mutamenti.
In un sistema che produce corpi dominanti e corpi subalterni c’è sempre quaolcunə più subalternə di un altrə e in questa piramide di sfruttamento è sufficiente stare un gradino sopra per sentirsi unə privilegiatə. È questo un altro dei motivi per cui il padrone continua a sfruttare lɜ lavoratorɜ. Étienne de La Boétie scriveva, infatti, che non sono gli eserciti a garantire il potere del tiranno, ma è quella rete di interessi privati che si struttura a partire dalle persone più vicine a quello e da queste si allarga fino a tal punto che «il numero di persone a cui la tirannia sembra vantaggiosa risulta quasi uguale a quello di chi preferirebbe la libertà».
E, ancora, c’è la fascinazione per il potere, c’è il desiderio recondito che servendo bene si possa diventare come il padrone: domani andrà meglio, domani sarà la mia occasione, ma solo se avrò pazienza oggi.
È sull’illusione di domani che si fondano le grandi disillusioni di oggi.
Eppure, afferma il giovane filosofo, sarebbe sufficiente decidersi a non servire per ritrovarsi immediatamente liberɜ e cita alcune personalità della storia che hanno goduto di questa libertà, si sono ribellate al tiranno, hanno smascherato l’inganno del potere. Dal ‘500 ad oggi molte altre sono state le esperienze di chi ha deciso di ribellarsi alla subalternità; la storia delle grandi rivoluzioni ha confermato quel semplice principio secondo cui tanto il signore quanto il padrone siedono sulle spalle dei servi.